Una riflessione personale sulla quadrilogia di Elena Ferrante (questa è una recensione spoiler, non leggere se non vuoi sapere come va a finire)
La quadrilogia dell’Amica Geniale (edizioni e/o) di Elena Ferrante è indubbiamente un capolavoro destinato a durare nei secoli, un’opera che continuerà ad avere sempre qualcosa da dire, come i più grandi classici.
Proprio per questo, almeno per me, diventa impossibile scrivere una recensione che non abbia un punto di vista ( il mio) e soprattutto una recensione che possa essere esauriente per le oltre mille pagine del romanzo.
L’Amica Geniale è il romanzo delle mille verità, che sono certa sia capace di parlare ad ognuno in un modo diverso, e raccontare intime e (scomode) verità ad ognuno di noi come singola persona,e questo già di per se è straordinario.
Quello che vorrei fare è parlarvi di cosa il romanzo ha significato per me, in questa prima lettura.
Chiudendo l’ultimo volume, non riesco a scrollarmi di dosso una sensazione di dolore profondo.
Non per la bellezza dell’opera – quella è innegabile – ma per ciò che racconta: la storia di due vite immerse in una sofferenza che sembra non dare mai tregua, incapaci di sbocciare davvero perché il dolore riempie ogni angolo della loro esistenza.
Un’amicizia che imprigiona più di quanto liberi
L’amicizia tra Elena e Lila, tanto celebrata dalla critica, mi appare spesso come una relazione profondamente tossica. Due donne che si nutrono l’una dell’altra in modo vampiresco, che si stimolano reciprocamente ma si logorano altrettanto sistematicamente.
Elena vive la sua intera esistenza nell’ombra di Lila, misurandosi ossessivamente con l’amica invece di trovare la propria strada autentica. Ogni successo, ogni scelta, ogni pensiero passa attraverso il filtro del confronto con Lila. È una forma di dipendenza che la priva della libertà di essere semplicemente se stessa.
Dall’altra parte, Lila sembra sabotare senza tregua le proprie possibilità di realizzazione, come se non riuscisse a sopportare l’idea di essere davvero libera, di abbandonare quel rione che pure detesta.
Si aiutano a sopravvivere, sì, ma non a sbocciare. Rimangono legate in una spirale che le tiene ancorate più di quanto le elevi, in un’amicizia che diventa vincolo più che spazio di crescita.
Un’amicizia spinosa e difficile, raccontata magistralmente, di cui anche il lettore diventa dipendente.
Il fascino devastante del narcisista: il caso Nino Sarratore
Una delle parti più incisive dell’intera quadrilogia, almeno per me, riguarda la figura di Nino Sarratore, ritratto con precisione chirurgica come un manipolatore seriale.
E sinceramente, tutto credevo di leggere, tranne di un amore a stampo narcisistico (ed è stato meraviglioso e inquietante leggerlo.)
È significativo (e la dice lunga su quanto questo tema sia attuale) che gran parte dell’opera sia dedicata a mostrare come questo personaggio riesca ad attirare nella propria rete sia Elena che Lila, due donne di straordinaria intelligenza.
Elena Ferrante maneggia il personaggio di Nino con una maestria diabolica. Dissemina indizi lungo tutta la narrazione – un gesto di indifferenza qui, una promessa vuota là, una seduzione calcolata altrove – costruendo un ritratto che si svela graduale ma inesorabile.
Il lettore assiste impotente mentre prima Lila e poi Elena scivolano nella sua rete, vivendo in prima persona le loro ossessioni amorose. Si rimane sospesi su un filo di angoscia costante perché Nino si ama e si odia contemporaneamente, perché non si riesce a lasciarlo andare anche quando la ragione urla di fuggire.
Nino incarna il fascino del narcisista che sa esattamente quali corde toccare, che fiuta le ferite emotive altrui e le sfrutta con una chirurgica precisione, ma che non supera mai la sua diabolica superficialità. Promette sempre quello che poi alla fine manca – libertà a Lila, riconoscimento intellettuale a Elena – per poi negarlo sistematicamente una volta ottenuto ciò che vuole.
Il fatto che due menti così acute cadano nella sua trappola dimostra una verità scomoda: il fascino narcisistico non ha nulla a che fare con l’intelligenza o la cultura. È una dinamica che colpisce nel profondo, sfruttando vulnerabilità ancestrali che spesso nemmeno riconosciamo in noi stessi – il bisogno di essere viste, di sentirsi speciali, di essere scelte.
È un amore cieco e dannato che devasta più di quanto arricchisca, e che la Ferrante descrive senza alcuno sconto. Un amore che si nutre di sofferenza e la perpetua all’infinito.
Le radici che non si recidono mai
Come nei Malavoglia di Verga, emerge prepotentemente il tema del destino scritto nel sangue e nella nascita.
Chi nasce povero, chi appartiene alla “plebe”, porta dentro di sé un marchio che sembra indelebile.
Ma la Ferrante introduce una variante cruciale: lo studio e una disciplina ferrea come quella di Elena possono aprire una breccia in questo muro, offrire una possibilità di fuga dal destino prestabilito.
Eppure, anche quando Elena conquista il mondo intellettuale, vince premi letterari, frequenta salotti colti, il rione non la abbandona mai. È come un’ombra che la segue ovunque vada, una voce interiore che le grida di essere sempre e comunque una “plebea travestita”.
Le origini diventano una cicatrice che non si rimargina, un’identità segreta che la perseguita anche nei momenti di maggior trionfo.
Elena può anche diventare una scrittrice affermata, ma quando torna al rione si sente immediatamente risucchiata nella sua vecchia pelle, nelle sue paure primitive. È come se Napoli e il rione possedessero una subdola forza magnetica che nessuna cultura potrà neutralizzare completamente.
Del resto, Napoli e il rione diventano essi stessi protagonisti assoluti della narrazione – personaggi concreti e violenti che modellano i destini dei personaggi. Ma di come Elena Ferrante scriva e mostri l’attaccamento di Napoli e del rione ai suoi personaggi, questa sarebbe materia per un’altra recensione.
Lo spreco di Lila: una tragedia esistenziale
È su Lila che si concentra la mia riflessione più dolorosa.
La sua esistenza mi appare come uno spreco immenso, una tragedia che mi colpisce più di ogni altra.
Lila aveva tutto per conquistare il mondo: un’intelligenza bruciante, una capacità di comprensione della realtà che superava quella di tutti gli altri personaggi, una forza d’animo straordinaria.
Eppure si autodistrugge.
È come se la violenza subita, l’orgoglio ferito, la paura di essere vulnerabile l’abbiano condannata a una forma di suicidio intellettuale ed emotivo. Le ferite interiori, la violenza, la perdita, l’orgoglio fine a se stesso possono davvero limitarci così tanto?
La risposta che emerge dall’opera è agghiacciante: sì, possono farlo.
La vita passa e si muore, e Lila sembra essersi dimenticata di vivere nonostante la sua immensa forza. La sua “smarginatura” finale – quel dissolversi, quello scomparire volontario – è insieme poetica e terribile. È la resa definitiva di chi aveva tutto per brillare ma ha scelto l’autoannientamento.
L’anatomia spietata dell’anima
Elena Ferrante conduce un’indagine psicologica di una precisione chirurgica. Ogni piega delle emozioni viene esplorata con un’intensità che toglie il fiato, come se assistessimo a una confessione urlata senza mezzi termini. Le sue parole hanno una sincerità così nuda che è impossibile non riconoscersi, impossibile non provare quella vergogna mista a sollievo di chi si vede finalmente riflesso senza filtri.
Prendiamo Lila: la vediamo rabbiosa e poi tenerissima, vendicativa e subito dopo generosa, imprenditrice spietata e madre premurosa. Ogni sfumatura è resa con una maestria che non concede sconti né al personaggio né al lettore. Non ci sono eroi o vittime – ci sono esseri umani nella loro contraddittoria pienezza.
È anche questa la forza della scrittura di Elena Ferrante: la capacità di spingersi nelle pieghe più profonde dell’anima umana, di esplorare senza reticenze paura, invidia, sessualità, avversione, rabbia, perdita. Non c’è romanticizzazione, edulcorazione. C’è la vita nella sua complessità più cruda e vera, quella che ognuno di noi riconosce, ma spesso non ci si sofferma o finge non vedere.
E, se c’è un tema che attraversa come un filo rosso tutta l’opera, è questo: siamo spesso noi stessi i nostri peggiori nemici.
Le nostre ferite diventano catene invisibili che ci impediscono di volare anche quando avremmo ali potentissime. Lila ne è l’esempio più straziante – geniale e autodistruttiva, capace di tutto eppure prigioniera di se stessa.
Un ultima domanda
Chiudendo questi quattro volumi, mi rimane una domanda: quante persone geniali si perdono non per mancanza di talento, ma per incapacità di guarire le proprie ferite? Quante Lila popolano il mondo, dotate di intelligenze straordinarie ma condannate all’autodistruzione dalle cicatrici dell’anima?
L’Amica geniale è un’opera che durerà nei secoli proprio perché tocca queste verità universali e scomode. È un nuovo classico che ci costringe a guardare negli abissi della condizione umana, e allo stesso modo dentro noi stessi così in profondità, senza offrire facili consolazioni o una verità assoluta, ma regalandoci la scottante potenza del mostrare vite e situazioni che appartengono, intimamente, ad ognuno di noi.
© 2025, Alessandra Gianoglio. All rights reserved.

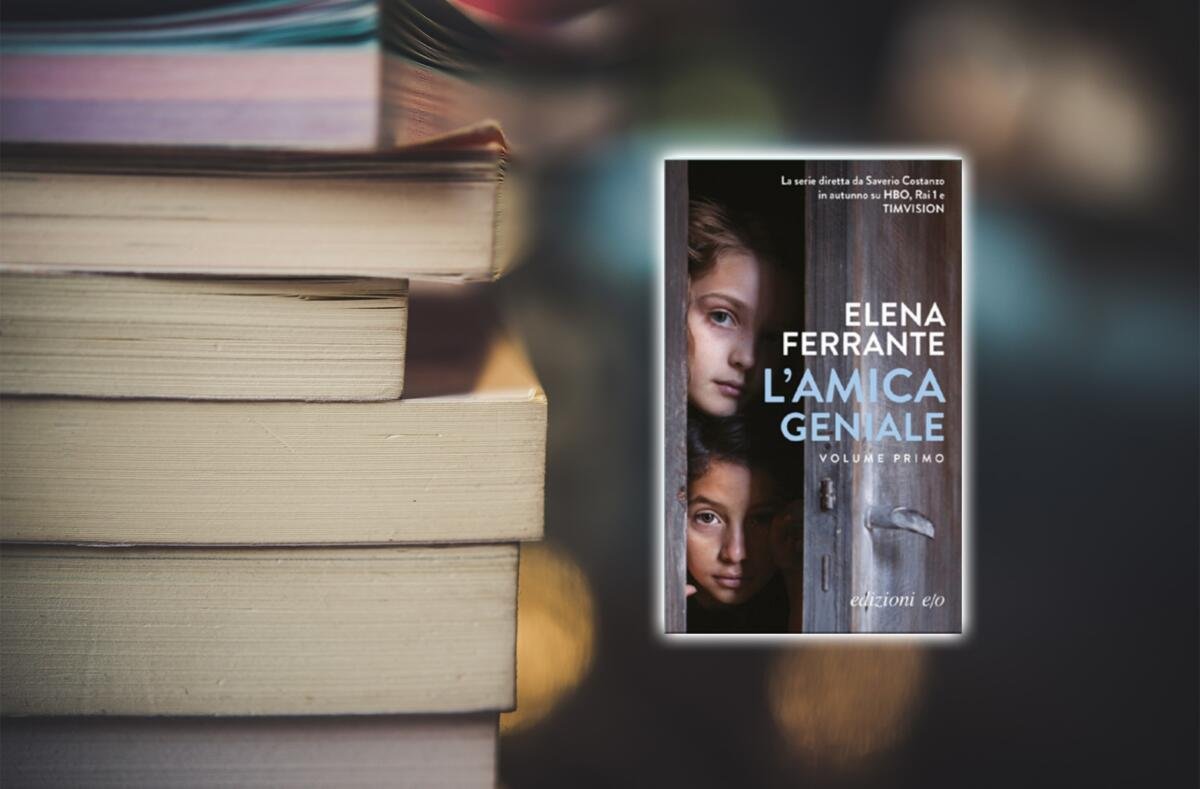


Leave a Comment